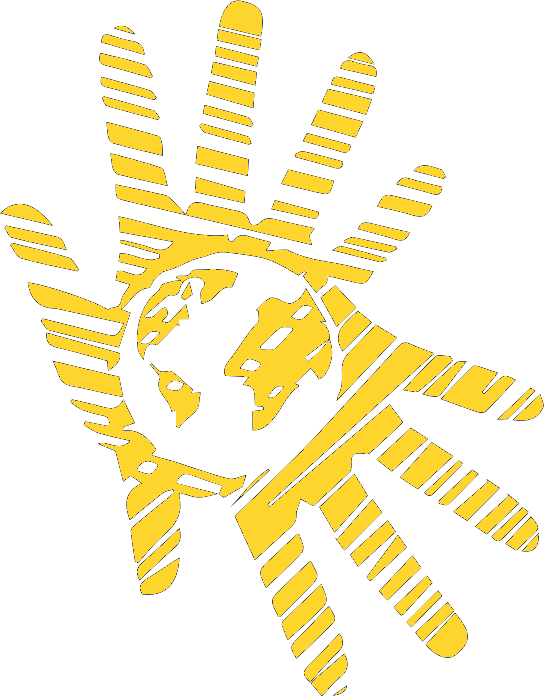Tre settimane fa, 44 persone sono arrivate in Italia, legalmente e in sicurezza, grazie all’ultimo Corridoio Umanitario gestito anche dalla nostra Cooperativa. Dietro questo dato c’è molto più di un semplice arrivo: c’è una complessa macchina organizzativa, una selezione rigorosa e, soprattutto, una sfida di integrazione che inizia subito.
Abbiamo chiesto al nostro vicepresidente, Giacomo Rondelli, di rispondere senza filtri alle domande che la nostra community ci pone più spesso, svelando i meccanismi concreti di questo progetto di salvezza. Chi finanzia queste operazioni? Quali criteri vengono usati per selezionare i beneficiari? E cosa succede concretamente nelle prime settimane in Italia? Tutte le risposte nell’intervista!
Ciao Giacomo! Partiamo subito con la prima domanda: come avviene concretamente il processo di selezione delle persone che beneficeranno dei Corridoi Umanitari? Quali criteri sono adottati e quali enti sono coinvolti?
Le persone vengono selezionate in base a dei criteri inseriti nel protocollo di Intesa tra il Governo italiano la Comunità di Sant’Egidio il Caritas italiana, ovvero vengono identificate le persone più fragili, anche se “fragilità” vuol dire un po’ tutto e niente, nel senso che dipende anche dal contesto. All’inizio venivano portati, soprattutto mamme con bambini, per farsi curare. Ci sono stati momenti nella storia dei corridoi umanitari in cui venivano coinvolte anche persone giovani, perché erano a rischio o di rientrare in guerra o in servizio militare. Quindi i corridoi seguivano l’evolversi delle situazioni del Corno d’Africa.
Oggi vengono selezionate persone anche in base alla presenza di contatti familiari o persone di appoggio in Italia o in Europa, perché ci siamo resi conto nel corso degli anni che laddove ci siano familiari o persone che possono prendersi in carico le persone migranti. per queste persone è più facile l’inserimento.
In questo periodo abbiamo cominciato ad aprire i corridoi soprattutto alle persone sudanesi, a causa dello scoppio della guerra. Nel caso di quest’ultimo corridoio umanitario le 44 persone selezionate sono tutte famiglie somale o sudanesi, appena uscite o dal Sudan – a causa della guerra che è scoppiata due anni fa e che sta producendo più di 4 milioni di sfollati- o dalla Somalia, che ancora oggi rimane uno dei paesi con il maggior numero di persone rifugiate, che scappano a causa di situazioni interne, di un governo poco stabile, di alcuni gruppi terroristi che ci sono ancora. Quindi queste 44 persone sono state le più idonee in base a questi principi. Sono state contattate fondamentalmente famiglie, soprattutto mamme con bambini, perché sono le persone più fragili all’interno dei campi profughi, quelle che fanno più fatica.
Chi finanzia i Corridoi Umanitari? Come vengono coperte le spese di un’operazione complessa come il viaggio (volo, documenti, logistica)?
Il progetto viene sostenuto da un accordo della Caritas italiana dove sostiene con l’8×1000 questo progetto, in piccola parte però, forniscono 15 euro a persona al giorno, che è poco per poter far fronte a molte esigenze. Noi facciamo appello anche ad altri canali, per esempio i nostri corridoi umanitari, vengono sostenuti anche dalla diocesi di Bologna con cui abbiamo un accordo e da altri enti privati o da persone che fanno donazioni.

Com’è stato il primo impatto in Italia per queste 44 persone? Quali sono state le emozioni o le prime necessità che avete riscontrato prima di partire e appena scesi dall’aereo?
Sicuramente le persone hanno vissuto il viaggio come il grande viaggio, un viaggio di speranza o il viaggio della loro vita. È stato molto commovente vederli partire all’aeroporto, dove hanno salutato magari amici o parenti o altre persone, altri rifugiati con cui hanno condiviso parte di questo cammino di fuga dal proprio paese. È chiaro che partono con grandi aspettative, benché sia stato chiarito loro un po’ di ciò che li aspetta in Italia, quindi le difficoltà che dovranno affrontare, portano con loro la speranza di trovare un posto dove ci sia pace e tranquillità, per potersi ricostruire. È un momento, l’impatto con l’Italia, molto delicato perché queste persone hanno una visione del nostro paese un po’ distorta, per cui è importante soprattutto far loro capire che, sicuramente, qui trovano la cosa più importante per adesso, che sono la libertà e la tranquillità, la pace, però poi c’è da costruire tutto un futuro che non è semplice, è complicato.
Quali sono i primissimi “passi burocratici” o amministrativi che la Cooperativa ha gestito per queste 44 persone subito dopo il loro arrivo (es. registrazione, documenti iniziali, richiesta di protezione)?
Quando le persone accolte tramite corridoi umanitari arrivano a Roma fanno il primo accesso alla richiesta di asilo proprio lì a Roma, perché loro entrano con un visto temporaneo emergenziale, ETD, il quale li viene poi preso alla frontiera Fiumicino. Per rimanere legali in Italia anche loro fanno tutto il procedimento della richiesta di asilo. I primi passi poi, quando arrivano a Bologna, prevedono di prendere contatti con la nostra questura, che viene già stata avvisata preventivamente, per andare a formalizzare la richiesta di asilo.
Comincia in seguito la gestione sanitaria, quindi ci adoperiamo per far avere loro un medico, soprattutto perché molti di loro, essendo fragili sia da un punto di vista fisico che psichico, hanno bisogno di medicine e quant’altro. L’altro passo primario è quello di cominciare, piano piano, con le questioni riguardanti la residenza, il domicilio, per far avere loro in mano i documenti. Questo avviene all’incirca all’interno del primo mese da quando le persone arrivano in Italia.

Durante le prime settimane come viene strutturata la quotidianità delle persone accolte? Quali attività caratterizzano la loro routine?
Le prime attività per le persone che arrivano in Italia sono sicuramente quelle di far capire in che contesto si trovano, ovvero dove sono. Sembra banale, ma una delle cose principali è insegnar loro a fare la spesa, perché non sono abituati. Capire quanto vale un euro, quanto spendere nella spesa, dove farla, come farla, quindi le prime settimane sono svolte proprio a fare degli accompagnamenti mirati e nello spiegare a queste persone come si devono muovere nella quotidianità, anche semplicemente come prendere l’autobus.
Dopo due settimane sono stati scritti alla scuola di italiano che è la prima attività fondamentale per poter cominciare a inserirsi in Italia.
Quali operatori o figure di riferimento sono stati immediatamente coinvolti per supportare le 44 persone nella loro prima fase di accoglienza in loco?
La cooperativa è composta da mediatori linguistici, in questo caso di madrelingua araba, che hanno già lavorato a Casa Berekèt e che sono di supporto. Le persone accolte sono inserite in un contesto in cui ci sono già altre famiglie, quindi anche un po’ più facili, non sono lasciati a se stessi. Ci sono operatori notturni, operatori e operatrici sociali, coordinatori, educatori sociali. C’è sempre una copertura H24, perché il primo periodo è il periodo più delicato in cui le persone sono un po’ più disorientate. Poi seguirà una seconda fase, in cui emergerà lo sforzo necessario per poter fare qualcosa, quindi la fatica dello scontro con la nostra realtà, e poi la terza fase, che è quella del rilancio, dopo aver vissuto lo sforzo, l’attesa, le persone iniziano a prendere le proprie cose, la propria vita e cominciano davvero a costruire un futuro qui in Italia.

Guardando avanti, in che modo il percorso che attende queste persone è un “ponte verso l’autonomia” e quali sono le prime basi gettate per la loro futura integrazione lavorativa e abitativa?
Credo che l’obiettivo principale dei corridoi umanitari non sia tanto l’autonomia, l’integrazione di queste persone, ma sia fondamentalmente quello di averle aiutate a tirarsi fuori da una situazione molto difficile e molto critica. Molte volte noi che andiamo sul campo ci poniamo un po’ questa domanda: se ha senso tutto questo che stiamo facendo conoscendo poi in Italia le fatiche, le difficoltà di queste persone, le poche opportunità che possono avere conoscendo le loro fragilità. Poi guardando dove vivono, guardando i contesti in cui sono, i contesti da cui vengono, la risposta è molto semplice, alla fine noi possiamo dargli un’opportunità, un’opportunità di ricostruirsi la vita in un paese libero, in un paese che li possa accogliere e li possa instradare, dopodiché ogni successo o fallimento è loro, noi possiamo semplicemente instradarli, dargli questa nuova opportunità. E credo che il valore dei corridoi umanitari sia questo, non tanto l’integrazione, l’autonomia, ma proprio quello di creare le condizioni perché queste persone, che hanno vissuto in situazioni di guerra tremende, possano avere una nuova opportunità.